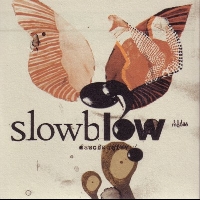 C’è ancora modo che qualche altro (ancora) artista islandese apra davanti a sé la porta della notorietà al di fuori dell’isola dei ghiacci, o vige una qualche forma di numero chiuso? E, già che ci siamo, come fa questa nazione ai confini del globo “utile”, in perenne sfida con le forze della natura – quindi naturalmente dedita a tutt’altro – a sfornare, in proporzione a una popolazione così sparuta, così tanti nomi di valore?
C’è ancora modo che qualche altro (ancora) artista islandese apra davanti a sé la porta della notorietà al di fuori dell’isola dei ghiacci, o vige una qualche forma di numero chiuso? E, già che ci siamo, come fa questa nazione ai confini del globo “utile”, in perenne sfida con le forze della natura – quindi naturalmente dedita a tutt’altro – a sfornare, in proporzione a una popolazione così sparuta, così tanti nomi di valore?
Qualunque sia la domanda da porre, bisogna premettere come gli Slowblow non siano affatto, per cronologia, gli ultimi arrivati di questa “ondata”. Orri Jonsson e Dagur Kàri Petursson fanno musica insieme da ormai un decennio, e prima di quest’album omonimo – che è sì il primo distribuito a livello internazionale – hanno anche firmato la colonna sonora di “Nòi Albinòi”, che in qualche nostra sala è pure passato, oltre ad aver lavorato con più illustri connazionali come Mùm ed Emiliana Torrini e ad essere stati oggetto di cover (‘Is Jesus Your Pal’) da parte dei Gus Gus.
Adesso era forse il caso di fare più le cose “sul serio”. Ed ecco che per il duo si sono aperte anche le porte dell’ormai celebre studio dei Sigur Ròs, quello che, in quanto ex-piscina coperta, sembra garantisca una particolare acustica. E anche a prescindere da questo dettaglio, il disco non è di quei progetti che si mettono su da un giorno all’altro, con i suoi 8 anni di lavorazione (ma hanno anche fatto altro, nel frattempo) e la massiccia quantità di strumenti coinvolti.
Di primo acchito sembrerebbe poter inserire il disco nel solco dreamy e modernamente fiabesco tracciato da alcuni dei nomi citati, ma la questione (fatta eccezione, forse, per la sola ‘Cardboard Box’, in cui, come in altri tre brani, c’è Kristìn Anna Valtysdottir dei Mùm alla voce) sembra essere diversa, e non solo per il particolare anagrafico che fa venire i nostri, negli annali, ben prima dei citati nomi. Certo non mancano certe quiete fascinazioni nordiche, ma il discorso portato avanti dagli Slowblow sembra voler prendere le distanze da una precisa contestualizzazione.
Ecco quindi che la maggior parte brani (con l’eccezione di cui sopra e di ‘Happiness in Your Face’, riuscitissimo esemplare di new-wave cadenzata e distorta con voce sparata in megafono) riecheggia le placide introspezioni alt-country, se non esplicitamente bluegrass (‘Aim for a Smile’), d’oltreoceano, l’originalità della cui firma va ricercata non solo nella ricchezza di dettagli sonori, ma anche nella voluta approssimazione, frutto di vecchi strumenti e registrazioni in parte home-made, con cui le canzoni vengono – appriopriatamente – “sporcate”.
Troppo facile innamorarsi di un disco così? Mah, l’importante è riuscirci… no?
Autore: Bob Villani

































