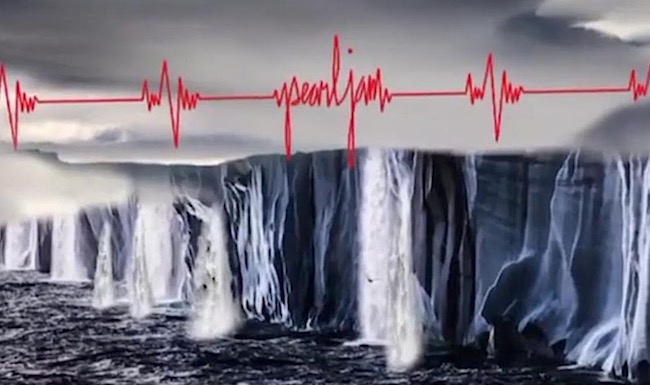Diciamolo subito: i Pearl Jam non sono cambiati. Il primo singolo, Dance of the Clairvoyants, aveva scioccato da una parte e esaltato dall’altra i loro fan che si dividono fra fondamentalisti del grunge e amanti dell’innovazione. Effetti al computer e bassi campionati introducono la “danza dei chiaroveggenti” che procede con un ritmo serrato, severo, fino alla conclusione con cori e controcori e voci doppie e triple nei quali, più che altrove nel pezzo, si sente effettivamente quella derivazione dai Talkin Heads di cui molti hanno detto. Ma il riferimento alla band di Byrne è più che altro una citazione: benché non ci siano le schitarrate, ma appunto beat e l’elettronica, il pezzo è totalmente, fortemente, indiscutibilmente marchiato PJ. Le chitarre, benché effettate in maniera diversa dal solito, ci sono sempre pur non facendo assoli ma sottili e sinuosi riff, e inoltre l’atmosfera cupa ricorda quella di pezzi come Nothing as it Seems, quindi non è nuova in assoluto. E’ del resto è l’unico pezzo (se si eccettua l’ultimo, River Cross, su cui torniamo dopo) fuori dalla tradizionale devozione della band di Seattle al più classico dei suoni rock, con le tre chitarre basso e batteria, che hanno sempre caratterizzato da 30 anni il loro fedelissimo suono. Infatti Who Ever Said e Superblood Wolfmoon con cui il disco inizia sono, nella migliore tradizione Pearl Jam, due pezzi tosti e ritmati pieni di chitarre, che ricordano però non tanto i Pearl Jam degli anni ’90 dell’epoca classica grunge, quanto piuttosto i dischi del 2000, da Markers in the Sand dell’omonimo Pearl Jam del 2006 a Do the Evolution di Yield o anche qualcosa di Riot Act.
Dopo questi e dopo DOTC, il disco procede ancora in stile classico con un altro rock ritmato quale Quick Escape, fino a piazzare al centro del disco la prima ballata, It’s Alright, anche questa in perfetto stile Pearl Jam (ricorda la tensione lirica di Oceans, o I’m Open o soprattutto cose più recenti come Speed of Sound o Sirens). Fino a questo punto, il disco non delude, si regge bene, e soprattutto supera il confronto (che tanto era inevitabile fare) con gli ultimi due, ovvero Backspacer e Lightning Bolt. Questi avevano forse alcuni singoli pezzi più belli, ma poi contornati da poco altro di valido, mentre Gigaton è soprattutto ben dettagliato: si sente subito che ci hanno lavorato tanto in fase di produzione e post-produzione, e questo giustifica senz’altro la scelta (anche questa molto “gridata”) di abbandonare il loro affezionato Brendan o’Brien e scegliere John Evans, che comunque garantisce una continuità stupefacente al suono storico della band, grazie anche all’astuzia di far registrare in presa diretta, benché solo a coppie di piste, poi mixate dopo.
Arriva poi Seven o’Clock, un pezzo inizialmente “leggero” e arioso, molto melodico, che poi evolve e diventa profondo fino a quel “Much to be Done”, gridato alla fine più volte da un Eddie ispiratissimo (anche questo è un pezzo di quelli che pure i Pearl Jam hanno lasciato qua e la nella loro discografia), poi altri due ottimi pezzi graffianti come Never Destination (chi temeva non ci fosse troverà qui la tirata di Eddie Vedder contro Trump) e Take the Long Way, entrambi con riff più pearljamiani che mai, poi l’album si lascia andare, anche troppo, a ritmi più lenti, acustici, nella triplice sequenza di Buckle Up, Comes then Goes e Retrograde.
Buckle Up è più un pezzo da carriera solista acustica di Vedder, anche se c’è la batteria oltre le chitarre acustiche a far la differenza, Comes then Goes è un’altra classica ballata acustica, dedicata (ma solo per evocazione) a Chris Cornell, davvero vicina a brani come quelli di Into the Wild tanto da poter benissimo stare lì dentro, mentre Retrograde ha forse il solo difetto di essere un pezzo semi-acustico e ballad che viene dopo altri due pezzi acustici, perché gli acuti evocativi finali di Eddie sono emozionanti.
River Cross conclude con un altro momento semi-inedito: si sentono organi, e questi domineranno per tutta la canzone, rendendola solenne e sontuosa, e sopra questi il canto di Eddie trionfa nel suo solito modo, quello a cui ci ha abituato la voce che in assoluto (dopo la debacle di Bono dal 2000 in poi) è la voce più bella del rock da vent’anni a questa parte. Fin qui le canzoni in se. C’è ancora molto da dire su questo disco, e molto anche è stato detto già: per esempio sulla presunta ispirazione ambientalista, che in realtà è solo nella copertina, del fotografo canadese Paul Nicklen, in cui si rappresenta un muro di ghiaccio a picco sull’acqua, quasi un paesaggio da Interstellar, se non fosse chiaro che qui la band evoca lo scioglimento dei ghiacci imminente. Sì, certo, nel disco si pubblicizzano due associazioni ambientaliste a cui Vedder si è legato in questo periodo, Seal Legacy e Only One, ma nei testi non ci sono cenni espliciti alla tematica. Semmai, si leggono in Dance of the Clairvoyants parole come “siamo bloccati nelle nostre scatole, perché non è più tutto aperto, avrebbero potuto sollevarci ma invece ci hanno dimenticato” e soprattutto in It’s Alright frasi come queste: “Va bene essere da soli, ascoltare un battito del cuore e sentire che è il tuo. Va bene acquietarsi, scomparire nell’aria sottile, e sapere che sei solo con te stesso”, che sembrano proprio essere riferiti all’emergenza COVID mondiale.
Comunque i testi complessivamente non deludono, come non hanno mai deluso: la penna di Eddie è sempre capace di evocare, graffiare, arrabbiarsi, ma anche essere dolcissima nel colorare atmosfere o emozioni o ricordi, come in una frase di Retrograde. “più sbagli, più risolverai, ci vuole molto di più di un amore ordinario per elevarsi, le stelle allineate ci diranno quando le cose vanno meglio di ora”.
Un disco dei Pearl Jam è già di per sé un evento, nella comunità rock. Un disco che esce dopo sette anni dall’ultima incisione è un evento enorme, decennale, potremmo dire. Gigaton è stato all’altezza di queste aspettative? La risposta non vuole essere salomoniana ma è: dipende.
Gigaton (Republic Records) non si avvicina nemmeno alle perle degli anni ’90, da Ten a Versus a Vitalogy o Yield, che sono senza alcun dubbio i loro dischi più belli e classici, quelli che consacrano i Pearl Jam come ultima definitiva vera band del rock-sangue-e-chitarre che abbia calcato la scena dagli anni ’90 in poi. Di grunge poi, non c’ è quasi traccia: tra acustici, lenti e ballate, Gigaton copre anche più della metà delle tracce. Ma ecco che se la pietra di paragone sono non soltanto i già citati Backspacer e Lightning Bolt, ma anche Riot Act, o Binaural, o persino No Code, questo disco ha qualcosa da aggiungere: proprio le ballate, i pezzi melodici, danno alla fine un tono, un’impronta, una identità speciale a questo disco. Vedder, Ament, Gossard e compagni sanno bene da molto tempo che gli anni ’90 di Seattle sono finiti anche per loro, e un po’ di stanchezza, vecchiaia, nella loro musica si sente, priva ormai di quel genio iniziale che li ha consacrati. Perciò da tempo fanno rock e non grunge, tuttavia fanno un rock onesto, serio, che non lascia nulla alla deriva commerciale, al coretto facile, alla canzoncina. Se in questo senso qualche scivolone c’è stato negli ultimi due, con questa grande attenzione alla produzione musicale Gigaton riprende quota, e perciò ricorda da vicino quei dischi come Riot Act dove non c’è Porch o Corduroy ma c’è tanta qualità, anche se in ritmi più sommessi.
In Gigaton insomma c’è qualità, e c’è intensità. Non abbastanza forse da gridare al capolavoro, alla rinascita, o al ritorno colossale dopo sette anni (si dovrebbe sentire per questo una discontinuità che nel suono non c’è), ma abbastanza da farci dire che i Pearl Jam confermano oggi di essere, con la trasmutazione degli U2 a gruppo pop smielato per tredicenni, con la deriva addirittura dance presa dai Coldplay da molti dischi a questa parte, con l’implosione dei Radiohead a nenia lamentosa e difficile che piace solo a loro stessi, gli unici fedeli interpreti di un rock anni ’90 puro, senza effetti, gli unici rappresentanti di un rock classico e non contaminato, rivendicata qui con serietà, professionalità, zero compromessi e tanta onestà intellettuale.
www.pearljam.com
www.republicrecords.com
autore: Francesco Postiglione